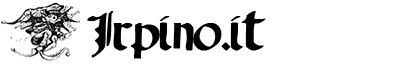-
Il dopo Scotellaro: trasformazioni epocali nel mondo contadino meridionale
Angelo Siciliano
 [Edito 25/09/2003] Percorrendo in auto le strade del Mezzogiorno d’Italia, in Irpinia, Puglia, Basilicata e Calabria ci s’imbatte spesso in antiche masserie e case agricole abbandonate. I loro muri perimetrali resistono ancora alle ingiurie del tempo, ma i tetti sono in parte o in tutto sfondati. È la conseguenza dell’abbandono, a seguito dei notevoli cambiamenti succedutisi, anche nel mondo contadino, nella seconda metà del Novecento. Le masserie, le Regiae massariae, erano il sistema d’organizzazione feudale dell’agricoltura, introdotto nel XIII secolo dall’imperatore Federico II, giunto sino a noi a metà Novecento. Ad occhio, s’intuisce che alcune di quelle masserie dovevano essere splendide, quando erano abitate e funzionanti, con centinaia di ettari di terra coltivata. Ancora oggi se ne può immaginare il decoro e la vitalità. Orgogliosi dovevano esserne i massari, che di solito ne erano gli affittuari, perché i proprietari, nobili o borghesi, risiedevano in città. I massari, che giravano a cavallo o col calesse (sciarabàllu), da quelle case-aziende gestivano, da padroni assoluti, stuoli di lavoratori ingaggiandoli nelle piazze dei paesi. Qui si radunavano i braccianti (jurnatiéri), che accorrevano talvolta anche da paesi lontani, per offrire le proprie braccia, dove si presumeva che vi fosse lavoro a sufficienza. Alcuni dei lavoranti per i massari, per la verità solo una piccola minoranza, erano assunti a metà agosto, con contratto annuale, e prendevano servizio l’otto settembre successivo. Si trattava di ualàni (bifolchi, bovari), lavuratóri (uomini in grado di svolgere differenti tipi di lavori), serve, picuràli e purcàri (pecorai e porcai). A parte le serve, erano detti tutti uarzùni (garzoni) e facevano ritorno alle proprie case ogni quindici giorni (quinnicìna), per rinsaldare il rapporto affettivo familiare, per la pulizia personale e la biancheria pulita. Lo ualànu era il capo dei dipendenti del massaro. Ne aveva la responsabilità, era pagato meglio degli altri, ma si alzava all’una di notte, per avviare le mucche al pascolo, e di giorno arava la terra con un aratro (pirticàra) tirato da due buoi aggiogati (rétina, parìcchju di vuóvi). Grave era lo sfruttamento del lavoro minorile sia nelle campagne che nelle botteghe artigiane. Già dall’età di cinque o sei anni, i minori, senza distinzione di sesso, erano obbligati a collaborare nel lavoro dei campi con i propri familiari. Alcuni maschietti erano affidati dalle proprie famiglie ai massari, come uarzùnciéddri, e lavoravano per anni interi come pastorelli. La loro paga annuale era costituita di solito da un maialino, che era ritirato dalla famiglia di appartenenza. Crescevano da analfabeti e tornavano a casa dalle proprie madri, solo in occasione delle feste religiose importanti che si tenevano in paese. Anch’essi potevano cambiare padrone a metà agosto. I dipendenti assunti per un anno intero erano detti salariati fissi, perché avevano diritto a ricevere vitto e alloggio dal massaro. Percepivano il salario per l’intero anno, sia in denaro che in beni, cioè grano, formaggio e maialini da fare allevare alle proprie consorti. Alcuni uarzùni ottenevano, dal massaro, la concessione di qualche pezzo di terra a mezzadria (tèrr’a la parte), da far coltivare alle proprie consorti. I braccianti, invece, erano assunti a tempo determinato, manodopera per i lavori più vari: zappatori, mietitori, raccoglitori, potatori, boscaioli ecc.. Erano pagati a giornata. Un’altra figura rilevante era il fattore. Egli curava gli interessi, facendone spesso le veci, del grande proprietario terriero che aveva scelto di dedicarsi personalmente alla coltivazione delle proprie terre, senza cederle a un massaro. Le colombaie delle masserie sono disertate da decenni dagli abituali frequentatori, i colombi. In qualche edificio rurale abbandonato, se i locali a piano terra sono ancora agibili, li si adopera come deposito di macchine e attrezzi agricoli, e non è raro notare, all’esterno di queste strutture, qualche carcassa malconcia di vecchia auto, in disuso e non rottamata, monumento involontario della civiltà tecnologica che è mutata velocemente. Molte case rurali furono edificate e consegnate ai contadini con i terreni agricoli circostanti, in attuazione della Riforma agraria. Spesso i criteri spartitori erano clientelari, ma quelle case furono abbandonate quasi subito, non appena ci si rese conto che le condizioni di vita erano misere, a causa di un reddito insufficiente, anche per una minima sussistenza. Oggi sono dei ruderi e rappresentano la parte più evidente degli avanzi della civiltà contadina, che ha tentato di innovarsi soccombendo alla modernità. Testimoniano di epoche in cui il 70-80% della popolazione, per lo più analfabeta, traeva sostentamento dalla coltivazione della terra e in parte dall’allevamento del bestiame. Sono i resti di una civiltà secolare, probabilmente millenaria, a cui l’archeologia sociale e l’antropologia, se non l’avessero già fatto, potrebbero rivolgere con profitto la propria attenzione. Il tempo provvederà a cancellare tutto, sotto l’azione disgregatrice degli agenti naturali.
[Edito 25/09/2003] Percorrendo in auto le strade del Mezzogiorno d’Italia, in Irpinia, Puglia, Basilicata e Calabria ci s’imbatte spesso in antiche masserie e case agricole abbandonate. I loro muri perimetrali resistono ancora alle ingiurie del tempo, ma i tetti sono in parte o in tutto sfondati. È la conseguenza dell’abbandono, a seguito dei notevoli cambiamenti succedutisi, anche nel mondo contadino, nella seconda metà del Novecento. Le masserie, le Regiae massariae, erano il sistema d’organizzazione feudale dell’agricoltura, introdotto nel XIII secolo dall’imperatore Federico II, giunto sino a noi a metà Novecento. Ad occhio, s’intuisce che alcune di quelle masserie dovevano essere splendide, quando erano abitate e funzionanti, con centinaia di ettari di terra coltivata. Ancora oggi se ne può immaginare il decoro e la vitalità. Orgogliosi dovevano esserne i massari, che di solito ne erano gli affittuari, perché i proprietari, nobili o borghesi, risiedevano in città. I massari, che giravano a cavallo o col calesse (sciarabàllu), da quelle case-aziende gestivano, da padroni assoluti, stuoli di lavoratori ingaggiandoli nelle piazze dei paesi. Qui si radunavano i braccianti (jurnatiéri), che accorrevano talvolta anche da paesi lontani, per offrire le proprie braccia, dove si presumeva che vi fosse lavoro a sufficienza. Alcuni dei lavoranti per i massari, per la verità solo una piccola minoranza, erano assunti a metà agosto, con contratto annuale, e prendevano servizio l’otto settembre successivo. Si trattava di ualàni (bifolchi, bovari), lavuratóri (uomini in grado di svolgere differenti tipi di lavori), serve, picuràli e purcàri (pecorai e porcai). A parte le serve, erano detti tutti uarzùni (garzoni) e facevano ritorno alle proprie case ogni quindici giorni (quinnicìna), per rinsaldare il rapporto affettivo familiare, per la pulizia personale e la biancheria pulita. Lo ualànu era il capo dei dipendenti del massaro. Ne aveva la responsabilità, era pagato meglio degli altri, ma si alzava all’una di notte, per avviare le mucche al pascolo, e di giorno arava la terra con un aratro (pirticàra) tirato da due buoi aggiogati (rétina, parìcchju di vuóvi). Grave era lo sfruttamento del lavoro minorile sia nelle campagne che nelle botteghe artigiane. Già dall’età di cinque o sei anni, i minori, senza distinzione di sesso, erano obbligati a collaborare nel lavoro dei campi con i propri familiari. Alcuni maschietti erano affidati dalle proprie famiglie ai massari, come uarzùnciéddri, e lavoravano per anni interi come pastorelli. La loro paga annuale era costituita di solito da un maialino, che era ritirato dalla famiglia di appartenenza. Crescevano da analfabeti e tornavano a casa dalle proprie madri, solo in occasione delle feste religiose importanti che si tenevano in paese. Anch’essi potevano cambiare padrone a metà agosto. I dipendenti assunti per un anno intero erano detti salariati fissi, perché avevano diritto a ricevere vitto e alloggio dal massaro. Percepivano il salario per l’intero anno, sia in denaro che in beni, cioè grano, formaggio e maialini da fare allevare alle proprie consorti. Alcuni uarzùni ottenevano, dal massaro, la concessione di qualche pezzo di terra a mezzadria (tèrr’a la parte), da far coltivare alle proprie consorti. I braccianti, invece, erano assunti a tempo determinato, manodopera per i lavori più vari: zappatori, mietitori, raccoglitori, potatori, boscaioli ecc.. Erano pagati a giornata. Un’altra figura rilevante era il fattore. Egli curava gli interessi, facendone spesso le veci, del grande proprietario terriero che aveva scelto di dedicarsi personalmente alla coltivazione delle proprie terre, senza cederle a un massaro. Le colombaie delle masserie sono disertate da decenni dagli abituali frequentatori, i colombi. In qualche edificio rurale abbandonato, se i locali a piano terra sono ancora agibili, li si adopera come deposito di macchine e attrezzi agricoli, e non è raro notare, all’esterno di queste strutture, qualche carcassa malconcia di vecchia auto, in disuso e non rottamata, monumento involontario della civiltà tecnologica che è mutata velocemente. Molte case rurali furono edificate e consegnate ai contadini con i terreni agricoli circostanti, in attuazione della Riforma agraria. Spesso i criteri spartitori erano clientelari, ma quelle case furono abbandonate quasi subito, non appena ci si rese conto che le condizioni di vita erano misere, a causa di un reddito insufficiente, anche per una minima sussistenza. Oggi sono dei ruderi e rappresentano la parte più evidente degli avanzi della civiltà contadina, che ha tentato di innovarsi soccombendo alla modernità. Testimoniano di epoche in cui il 70-80% della popolazione, per lo più analfabeta, traeva sostentamento dalla coltivazione della terra e in parte dall’allevamento del bestiame. Sono i resti di una civiltà secolare, probabilmente millenaria, a cui l’archeologia sociale e l’antropologia, se non l’avessero già fatto, potrebbero rivolgere con profitto la propria attenzione. Il tempo provvederà a cancellare tutto, sotto l’azione disgregatrice degli agenti naturali. -
Dibattito sul film di Mel Gibson “La passione di Cristo”
 [Edito 12/05/2004] Montecalvo Irpino AV – Il grande successo dell’ultimo film del regista americano Mel Gibson, ha favorevolmente impressionato e contagiato l’ambiente della nostra comunità parrocchiale, tanto da impegnare il nostro parroco, il vulcanico Don Teodoro Rapuano, nell’organizzazione di un dibattito – conferenza, dove si tenterà di dare risposta alle tante domande che sono sorte spontanee nelle coscienze dei montecalvesi che hanno già visto il film e di quelli che lo vedranno nei prossimi giorni. Interrogarsi e ottenere risposte sulle problematiche che il film di Gibson esprime, particolarmente nella “rappresentazione del dolore” delle ultime dodici ore della vita di Gesù Cristo, espressa con particolare tensione, dimostra senz’altro la volontà di compiere un salto di qualità del nostro modo di essere “cristiani”. Ed è partendo da queste considerazioni che l’incontro dibattito del 12 maggio presso il cinema Pappano si preannuncia come una seria oppurtunità da cogliere per confrontarsi su tematiche fondamentali, come quelle della religiosità, della sofferenza, dell’amore e della tolleranza, oggi alla base della costruzione di un nuovo sistema di vita che più che mai deve essere globale ed incidere sulle coscienze di ogni essere umano. Ringraziamo Don Teodoro, per il tempismo con il quale, ancora una volta è riuscito a percepire e ad essere pronto a rispondere alle esigenze spirituali di tutta la comunità parrocchiale montecalvese. [Nativo]
[Edito 12/05/2004] Montecalvo Irpino AV – Il grande successo dell’ultimo film del regista americano Mel Gibson, ha favorevolmente impressionato e contagiato l’ambiente della nostra comunità parrocchiale, tanto da impegnare il nostro parroco, il vulcanico Don Teodoro Rapuano, nell’organizzazione di un dibattito – conferenza, dove si tenterà di dare risposta alle tante domande che sono sorte spontanee nelle coscienze dei montecalvesi che hanno già visto il film e di quelli che lo vedranno nei prossimi giorni. Interrogarsi e ottenere risposte sulle problematiche che il film di Gibson esprime, particolarmente nella “rappresentazione del dolore” delle ultime dodici ore della vita di Gesù Cristo, espressa con particolare tensione, dimostra senz’altro la volontà di compiere un salto di qualità del nostro modo di essere “cristiani”. Ed è partendo da queste considerazioni che l’incontro dibattito del 12 maggio presso il cinema Pappano si preannuncia come una seria oppurtunità da cogliere per confrontarsi su tematiche fondamentali, come quelle della religiosità, della sofferenza, dell’amore e della tolleranza, oggi alla base della costruzione di un nuovo sistema di vita che più che mai deve essere globale ed incidere sulle coscienze di ogni essere umano. Ringraziamo Don Teodoro, per il tempismo con il quale, ancora una volta è riuscito a percepire e ad essere pronto a rispondere alle esigenze spirituali di tutta la comunità parrocchiale montecalvese. [Nativo]Alfonso Caccese
-
S. Maria antico splendore e nuovi misteri
 [Edito 23/03/2002] Montecalvo Irpino AV – Dopo quarant’anni, ieri sera, grazie a don Teodoro Rapuano ed alla buona volontà dei parrocchiani, la chiesa collegiata di Santa Maria Assunta è stata riaperta al culto dei fedeli. L’Arcivescovo di Benevento S. E. Serafino Sprovieri, davanti a centinaia di persone, ha celebrato il rito della nuova dedicazione, rito che in passato hanno già officiato il cardinale Piazza, futuro patriarca di Venezia, nel 1937 e Vincenzo Maria Orsini, futuro papa Benedetto XIII, nel 1693, infatti, i vari terremoti hanno, di volta in volta, decretato la chiusura della chiesa. Ma la passione che i fedeli hanno verso la loro chiesa madre ha sempre fatto sì che essa risorgesse; in stile tardo gotico, con i caratteristici archi a sesto acuto e l’inserimento in una navata laterale di una cappella rinascimentale, attribuita da alcuni studiosi alla scuola del Bramante, la chiesa è uno dei luoghi simbolo di Montecalvo. In essa è stato battezzato ed ha celebrato messa, S. Pompilio Maria Pirrotti. L’arcivescovo Sprovieri, nel suo discorso ai fedeli, ha sottolineato la grandezza di S. Pompilio ed a proposito del Santo ha parlato del recente ritrovamento della statua della Madonna dell’Abbondanza: “In questa chiesa manca ancora la padrona di casa – ha detto riferendosi alla statua – cioè la mamma che qui è configurata nella Madonna dell’Abbondanza – a questo punto è stato interrotto da un forte applauso ed ha continuato – che porta con sé un mistero ed è colma di affetto dei nostri avi. Una statua che non è ancora qui – infatti si trova nei depositi della soprintendenza, dove è stata restaurata a tempo di record, in attesa della presentazione ufficiale – ma che lo sarà presto, con il suo mistero che può sembrare inquietante ma che è, per me, esaltante. A guardarla le nostre pupille si riempiono della sua tenerezza. I suoi occhi cosa portano? Portano l’immagine della nostra realtà fatta, spesso, di peccatori. Come i tralci tagliati, l’uomo che si distacca da Dio secca e muore, conserva le sue sembianze ma spiritualmente diventa uno scheletro ed un teschio. Guarderemo la statua con attenzione, ma non per leggervi cattivi presagi”. Alla cerimonia religiosa erano presenti numerose autorità civili tra le quali il sindaco Alfonso Caccese ed Alfredo Siniscalchi, alto dirigente della presidenza del consiglio. Tra le autorità religiose Mons. Pompilio Cristino della curia di Benevento.
[Edito 23/03/2002] Montecalvo Irpino AV – Dopo quarant’anni, ieri sera, grazie a don Teodoro Rapuano ed alla buona volontà dei parrocchiani, la chiesa collegiata di Santa Maria Assunta è stata riaperta al culto dei fedeli. L’Arcivescovo di Benevento S. E. Serafino Sprovieri, davanti a centinaia di persone, ha celebrato il rito della nuova dedicazione, rito che in passato hanno già officiato il cardinale Piazza, futuro patriarca di Venezia, nel 1937 e Vincenzo Maria Orsini, futuro papa Benedetto XIII, nel 1693, infatti, i vari terremoti hanno, di volta in volta, decretato la chiusura della chiesa. Ma la passione che i fedeli hanno verso la loro chiesa madre ha sempre fatto sì che essa risorgesse; in stile tardo gotico, con i caratteristici archi a sesto acuto e l’inserimento in una navata laterale di una cappella rinascimentale, attribuita da alcuni studiosi alla scuola del Bramante, la chiesa è uno dei luoghi simbolo di Montecalvo. In essa è stato battezzato ed ha celebrato messa, S. Pompilio Maria Pirrotti. L’arcivescovo Sprovieri, nel suo discorso ai fedeli, ha sottolineato la grandezza di S. Pompilio ed a proposito del Santo ha parlato del recente ritrovamento della statua della Madonna dell’Abbondanza: “In questa chiesa manca ancora la padrona di casa – ha detto riferendosi alla statua – cioè la mamma che qui è configurata nella Madonna dell’Abbondanza – a questo punto è stato interrotto da un forte applauso ed ha continuato – che porta con sé un mistero ed è colma di affetto dei nostri avi. Una statua che non è ancora qui – infatti si trova nei depositi della soprintendenza, dove è stata restaurata a tempo di record, in attesa della presentazione ufficiale – ma che lo sarà presto, con il suo mistero che può sembrare inquietante ma che è, per me, esaltante. A guardarla le nostre pupille si riempiono della sua tenerezza. I suoi occhi cosa portano? Portano l’immagine della nostra realtà fatta, spesso, di peccatori. Come i tralci tagliati, l’uomo che si distacca da Dio secca e muore, conserva le sue sembianze ma spiritualmente diventa uno scheletro ed un teschio. Guarderemo la statua con attenzione, ma non per leggervi cattivi presagi”. Alla cerimonia religiosa erano presenti numerose autorità civili tra le quali il sindaco Alfonso Caccese ed Alfredo Siniscalchi, alto dirigente della presidenza del consiglio. Tra le autorità religiose Mons. Pompilio Cristino della curia di Benevento.Angelo Corvino
[Crediti Foto│...] -
La spunta Di Rubbo. E’ lui il candidato
 [Edito 13/04/2004] Montecalvo Irpino AV – Sciolto il nodo in casa Margherita. Il candidato a sindaco della coalizione sarà Giancarlo Di Rubbo, 45 anni, maresciallo della Finanza, sposato con Sabrina Montanari con la quale ha due figli. Presta servizio presso il comando dalla Guardia di Finanza di Benevento dove vive da circa 12 anni dopo aver vissuto a lungo a Rimini. I genitori vivevano a Corsano dove lui è nato e con il quale ha mantenuto sempre rapporti stretti al punto che ci torna anche 3-4 volte a settimana. Insomma praticamente è come se non fosse mai andato via. Il suo nome è venuto fuori dalla riunione di mercoledì sera della Margherita. L’ha spuntata sull’altro pretendente Gianni Iorio. Il partito ha decretato la sua investitura e sarà lui che affronterà Carlo Pizzillo nella prossima campagna elettorale. La decisione è stata lunga e sofferta ma alla fine nel partito è prevalsa la linea del buon senso da parte di tutti. Gianni Iorio da uomo di partito ha fatto un passo indietro ed ha lasciato il campo libero all’avversario. “Non potevo spaccare il partito – dichiara a caldo Iorio – era una responsabilità troppo grande”. Ora si registrano animi sereni in casa del Fiorellino dove si punta alla formazione della lista. D’altra parte sarebbero stati anche fissati i criteri per la nomina degli assessori. Tranne ripensamenti i posti nell’esecutivo, in caso di vittoria, saranno affidati agli eletti che prenderanno più voti, uno stimolo in più a darsi da fare. Fa eccezione la carica di vicesindaco che dovrebbe andare a Gianni Iorio, salvo una sua disfatta elettorale. “Ringrazio il partito e soprattutto Alfonso Caccese che mi ha indicato come suo sostituto – dice Giancarlo Di Rubbo – dico sostituto perché lui sarà nella lista e sarà il capolista. Ringrazio anche Iorio, uomo di partito, che nella dialettica politica ha accettato di farmi fare il candidato a sindaco. Ringrazio tutti gli esponenti del partito. Ora siamo tutti uniti con serenità e tranquillità. Alcuni avrebbero preferito Iorio per la maggiore presenza tra la gente. Ma ognuno di noi ha avuto un ruolo nell’amministrazione, siamo stati tutti bravi e siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. Spero di continuare con la stessa squadra di prima. Ora dobbiamo pensare ad ultimare la lista che è quasi ultimata ed affrontare la campagna elettorale”.
[Edito 13/04/2004] Montecalvo Irpino AV – Sciolto il nodo in casa Margherita. Il candidato a sindaco della coalizione sarà Giancarlo Di Rubbo, 45 anni, maresciallo della Finanza, sposato con Sabrina Montanari con la quale ha due figli. Presta servizio presso il comando dalla Guardia di Finanza di Benevento dove vive da circa 12 anni dopo aver vissuto a lungo a Rimini. I genitori vivevano a Corsano dove lui è nato e con il quale ha mantenuto sempre rapporti stretti al punto che ci torna anche 3-4 volte a settimana. Insomma praticamente è come se non fosse mai andato via. Il suo nome è venuto fuori dalla riunione di mercoledì sera della Margherita. L’ha spuntata sull’altro pretendente Gianni Iorio. Il partito ha decretato la sua investitura e sarà lui che affronterà Carlo Pizzillo nella prossima campagna elettorale. La decisione è stata lunga e sofferta ma alla fine nel partito è prevalsa la linea del buon senso da parte di tutti. Gianni Iorio da uomo di partito ha fatto un passo indietro ed ha lasciato il campo libero all’avversario. “Non potevo spaccare il partito – dichiara a caldo Iorio – era una responsabilità troppo grande”. Ora si registrano animi sereni in casa del Fiorellino dove si punta alla formazione della lista. D’altra parte sarebbero stati anche fissati i criteri per la nomina degli assessori. Tranne ripensamenti i posti nell’esecutivo, in caso di vittoria, saranno affidati agli eletti che prenderanno più voti, uno stimolo in più a darsi da fare. Fa eccezione la carica di vicesindaco che dovrebbe andare a Gianni Iorio, salvo una sua disfatta elettorale. “Ringrazio il partito e soprattutto Alfonso Caccese che mi ha indicato come suo sostituto – dice Giancarlo Di Rubbo – dico sostituto perché lui sarà nella lista e sarà il capolista. Ringrazio anche Iorio, uomo di partito, che nella dialettica politica ha accettato di farmi fare il candidato a sindaco. Ringrazio tutti gli esponenti del partito. Ora siamo tutti uniti con serenità e tranquillità. Alcuni avrebbero preferito Iorio per la maggiore presenza tra la gente. Ma ognuno di noi ha avuto un ruolo nell’amministrazione, siamo stati tutti bravi e siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. Spero di continuare con la stessa squadra di prima. Ora dobbiamo pensare ad ultimare la lista che è quasi ultimata ed affrontare la campagna elettorale”. [Credit Foto│Franco D'Addona]Angelo Corvino
-
Le BOLLE della MALVIZZA
Mario Sorrentino
 [Edito 00/00/0000] Viene così chiamato un luogo in cui si manifesta un fenomeno di vulcanesimo minore con fango perennemente ribollente.
[Edito 00/00/0000] Viene così chiamato un luogo in cui si manifesta un fenomeno di vulcanesimo minore con fango perennemente ribollente.
Nelle immediate vicinanze di questo posto dal nome un po’ sinistro sorgeva un tempio italico molto probabilmente dedicato alla dea Mephites, divinità importante nel pantheon sannita. Era una dea che si ritiene sia stata collegata ritualmente agli Inferi e, di conseguenza, all’alternarsi delle due opposte stagioni della primavera e dell’autunno, come la Proserpina latina e la greca Persèfone, e, cosa rilevante per la Malvizza (che era crocevia di tratturi e importante stazione dell’antico e principale tratturo tra Pescasseroli (Abruzzo) e Candela (Puglie), questa dea era anche invocata nei culti di fertilità degli animali (pecore,essenzialmente) che a milioni di capi transitavano e si fermavano in questo nostro luogo in primavera e in autunno. La transumanza che interessava il nostro territorio sino alla metà degli anni ’50 del secolo appena trascorso era cominciata nei lontanissimi tempi preistorici, prima di tutto come migrazione spontanea delle mandrie degli animali bradi, richiamati alternativamente dai prati estivi di montagna e quelli invernali di pianura; per finire poi come spostamento organizzato da parte delle varie civiltà umane succedutesi nei territori attraversati dal tratturo (da noi, popoli della civiltà appenninica, sanniti, romani, ecc.)
Dobbiamo al dott. Roberto Patrevita, del museo archeologico di Ariano Irpino, l’informazione che alla Malvizza sono stati trovati, durante gli scavi per un invaso d’irrigazione, alcuni reperti di un tempio italico, tra i quali una antefissa di terracotta del frontone del tempio, con su effigiato in rilievo un volto femminile visto di profilo, probabilmente proprio quello della dea Mephites. Il prezioso reperto si trova attualmente a Benevento, custodito dalla “Sovrintendenza per i beni archeologici delle province di Benevento, Avellino e Salerno” (non sappiamo se visibile per il pubblico).
Sempre il dott. Patrevita ci ha informati che templi italici dedicati alla dea Mefite erano dislocati un po’ dappertutto lungo il percorso del tratturo Pescasseroli-Candela, tra i quali, non lontani dalla Malvizza, quello di Casalbore, altra importante stazione del tratturo (probabilmente distrutto durante la seconda Guerra Punica, nel 217 a.C.) e un altro nel territorio di Greci, i cui reperti sono custoditi nel museo archeologico di Ariano Irpino.
In una delle nostre immagini è possibile scorgere in distanza la quercia centenaria che domina solitaria gli scavi di Aequum Tuticum. [Nativo]
-
Il PONTE delle CHIANCHE
Mario Sorrentino
 [Edito 00/00/0000] Ponte romano della Via Traiana, costruito all’inizio del II° sec. d.C. Ha tre arcate ancora esistenti con una quarta arcata separata dalle rimanenti interamente e malamente ristrutturata con materiali non originali. Sussiste anche quasi integra la pavimentazione del piano viario di bàsoli, chiamati nel dialetto locale “chianche” (da cui il nome attuale del ponte). Si trova a circa due chilometri verso valle, in direzione del fiume Miscano. Serviva a superare un torrente ora quasi asciutto.
[Edito 00/00/0000] Ponte romano della Via Traiana, costruito all’inizio del II° sec. d.C. Ha tre arcate ancora esistenti con una quarta arcata separata dalle rimanenti interamente e malamente ristrutturata con materiali non originali. Sussiste anche quasi integra la pavimentazione del piano viario di bàsoli, chiamati nel dialetto locale “chianche” (da cui il nome attuale del ponte). Si trova a circa due chilometri verso valle, in direzione del fiume Miscano. Serviva a superare un torrente ora quasi asciutto.
Opera probabile di Apollodoro di Damasco, architetto e scultore, al quale la critica moderna, oltre alle opere già attribuitegli dagli scrittori classici, ha aggiunto, tra le altre, il Foro di Traiano di Roma, con la celebre Colonna istoriata con bellissimi bassorilievi sulla guerra in Dacia dell’imperatore, ed anche, per ciò che ci interessa qui, l’Arco di Traiano di Benevento (v. R. Bianchi Bandinelli, alla voce “Apollodoro di Damasco”, in “Encicl. Dell’Arte Ant.”, Roma, 1958). L’Arco di Benevento fu inaugurato dallo stesso imperatore, nel 114 d.C., come porta a capo della Via Traiana realizzata nel biennio 109-110, alla biforcazione con la più antica via consolare dell’Appia, entrambe conducenti a Brindisi.
Una somiglianza illuminante sulla probabile attribuzione del Ponte delle Chianche ad Apollodoro è quella esistente tra le facce delle arcate di questo ponte e quello certamente più maestoso sul Danubio, a Dobreta (Romania), sicuramente opera dell’architetto preferito di Traiano, a sezioni trapezoidali, che però nel ponte di Buonalbergo possono decifrarsi con difficoltà, dato che il suo rivestimento litico originario giace disperso nel greto del torrente. [Nativo] -
Scavi archeologici di AEQUUM TUTICUM
Mario Sorrentino
 [Edito 00/00/0000] Aequum Tuticum era uno degli oppida che fungeva da capitale federale dei Sanniti, oltre che per la sua importanza come una delle principali stazioni dei tratturi della transumanza risalenti alla civiltà appenninica pre-sannitica, anche come centro di riunione dell’intero popolo dei Sanniti ( tuticum è aggettivo derivante da touto = “popolo” in osco) quando dovevano esser prese importanti decisioni politiche in pace o in guerra.
[Edito 00/00/0000] Aequum Tuticum era uno degli oppida che fungeva da capitale federale dei Sanniti, oltre che per la sua importanza come una delle principali stazioni dei tratturi della transumanza risalenti alla civiltà appenninica pre-sannitica, anche come centro di riunione dell’intero popolo dei Sanniti ( tuticum è aggettivo derivante da touto = “popolo” in osco) quando dovevano esser prese importanti decisioni politiche in pace o in guerra.
La quercia visibile in una delle immagini può far pensare al culto alla dea Kerres (il nome quercia nella forma dialettale locale deriva infatti dal nome della dea: Kèrres>Kèrs>Cèrz-a). E la capacità rigenerativa secolare delle querce, per mezzo dei polloni che accestiscono alla base dei loro tronchi non esclude che proprio lì ci fossero una o più querce sacre agli abitanti di Aequum Tuticum.
Dal sito archeologico sono visibili a uno due chilometri di distanza le “Bolle” mefitiche della Malvizza (territorio di Montecalvo Irpino), dove esisteva un tempio italico dedicato alla dea Mefite [Nativo] -
Un apostolo umile e semplice del Settecento
Cosmo Francesco Ruppi
 [Edito 16/03/2004] Fra qualche giorno si compiono settant’anni dalla canonizzazione di un apostolo del settecento, san Pompilio Maria Pirrotti delle Scuole Pie, nato in un paese dell’Irpinia, a Montecalvo Irpino, e morto a Campi Salentina, nei pressi di Lecce, ove è tuttora conservato il suo corpo. Nel paese del Salento, per la verità, visse appena l’ultimo anno della sua esistenza terrena, ma la sua memoria lì sempre viva, ben sorretta dallo zelo dei padri scolopi, la confluiscono non di rado pellegrini di molte parti d’Italia.
[Edito 16/03/2004] Fra qualche giorno si compiono settant’anni dalla canonizzazione di un apostolo del settecento, san Pompilio Maria Pirrotti delle Scuole Pie, nato in un paese dell’Irpinia, a Montecalvo Irpino, e morto a Campi Salentina, nei pressi di Lecce, ove è tuttora conservato il suo corpo. Nel paese del Salento, per la verità, visse appena l’ultimo anno della sua esistenza terrena, ma la sua memoria lì sempre viva, ben sorretta dallo zelo dei padri scolopi, la confluiscono non di rado pellegrini di molte parti d’Italia.
Il nome e le gesta di questo santo, per la verità, sono ben poco conosciuti, eppure è non solo contemporaneo di San Leonardo di Porto Maurizio, San Paolo della Croce e Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, ma ha con essi molto in comune e rappresenta un tratto significativo di quei settecento, definito da molti come il secolo scettico ed ateo, che registrò anche fulgori di santità.
Di san Pompilio, canonizzato da Pio XI il 19 marzo 1934, insieme a due altri beati, Giuseppe Benedetto Cottolengo e Teresa Margherita Redi, si scrisse che la sua santità obbediva al calmo fervore quotidiano. Di lui, Pio XI mise in luce come «la sua vita nascosta con Cristo in Dio congiunse l’infaticabile servizio dell’attività apostolica».
La caratteristica del santo irpino e salentino è quella di aver donato tutto se stesso per l’educazione dei giovani e del popolo minuto: «Egli — disse Papa Ratti — è un esempio chiarissimo che dimostra quanto la religione cattolica possa contribuire alla vera educazione della società civile». È forse per questo, che la sua vita e il suo esempio possono essere riproposti anche oggi alla nostra attenzione, in un momento in cui si scopre l’importanza dell’educazione cristiana e la responsabilità della famiglia, degli operatori scolastici e della stessa comunità cristiana in ordine alla educazione delle future generazioni. -
Meritata vittoria del Montecalvo nel recupero con il Gesualdo
Redazione

De Feo [Edito 00/03/2004] Dopo il pari con il Real Serino, per la compagine del patron Sabatino arrivano tre punti fondamentali nel lungo cammino verso la salvezza. Raggiunta quota 25 in classifica, il Montecalvo lascia i bassifondi e si porta a soli due punti dal Gesualdo che resta a 27. Per la cronaca, accade tutto nella ripresa. Al 10′ passa il Gesualdo con Di Rienzo. Poi la svolta per i locali: due cambi, due reti. A 20′ dal termine fuori Melillo, in campo il bomber Impronta. Dopo 30′ la punta entra in area e subisce fallo. Rigore. Dal dischetto va lo stesso Impronta, freddo nel realizzare il suo settimo centro stagionale. A 5′ dal termine esce Santini, spazio a De Vita. Ed è proprio il centrocampista a pescare il jolly al 90′. Rimessa corta del Gesualdo, De Feo crossa, De Vita stoppa ed in diagonale regala ai suoi un vittoria meritata.
[Credit│Il Mattino] -
LO CHIAMAVANO “PADRE SANTO”
Tarcisio Arnesano
[Edito 21/03/2004] Campi Salentina, a pochi chilometri da Lecce, si appresta a celebrare il 70″ anniversario della canonizzazione di san Pompilio Maria Pirrotti, sacerdote e religioso delle Scuole Pie, di cui custodisce le spoglie nel santuario a lui dedicato. Dichiarato santo da Pio XI il 19 marzo 1934. Nato nel 1710 a Montecalvo Irpino (Av) dalla nobile famiglia Pirrotti, Pompilio a 16 anni abbandonò la casa paterna per raggiungere Benevento, dove entra presso le Scuole Pie. Ordinato sacerdote, fu maestro e poi insegnante di retorica per 8 anni. Quindi esercitò la docenza, la predicazione, la confessione e la direzione spirituale. In tempi in cui si diffondevano idee filosofiche e politiche che favorivano l’anticlericalismo e le idee gianseniste allontanavano i fedeli dai sacramenti, in particolare dall’Eucaristia, padre Pompilio predicava l’amore e la misericordia di Dio, la sofferenza che unisce a Cristo crocifisso, la devozione al Cuore di Gesù e Maria e la vocazione di tutti alla santità. Ovunque folle di fedeli lo seguivano per ascoltarne la parola e per ricevere i Sacramenti, lo chiamavano «Padre santo» anche per i suoi numerosi prodigi. Il suo incessante pellegrinaggio apostolico, pur tra difficoltà, conflitti e incomprensioni, durò 25 anni e toccò varie città d’Italia (Ortona, Lanciano, Napoli, Chieti, Ancona, Lugo di Romagna, Manfredonia). Nel 1765 fu mandato nella Casa scolopica di Campi Salentina, in un momento difficile per la Comunità religiosa e l’Istituto scolastico. Padre Pompilio riuscì a cambiare l’ambiente comunitario e a migliorare le scuole, la chiesa, l’oratorio e il noviziato.