The road from Ariano Irpino – Louis A. de Furia
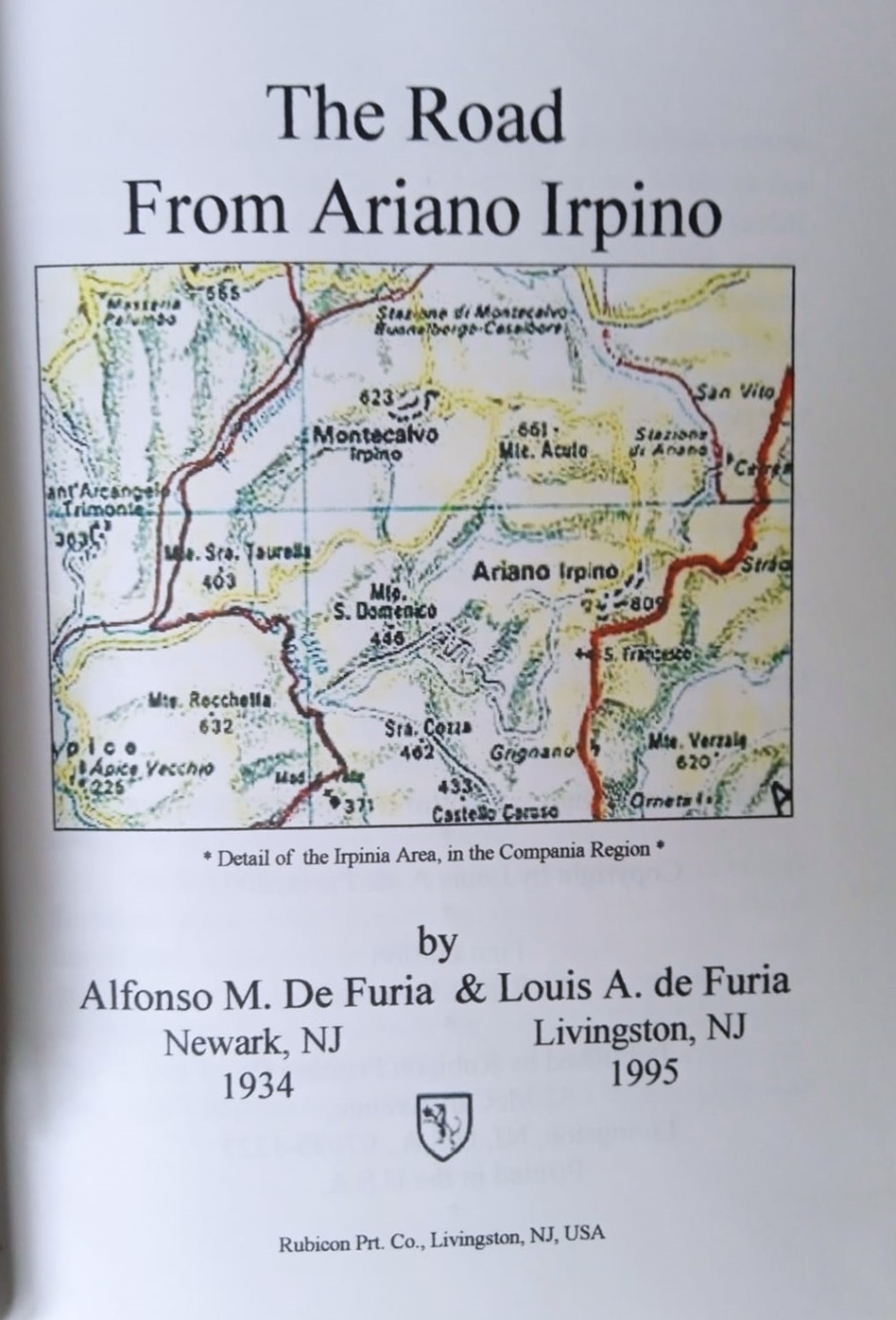 [Ed. 00/06/2003] Quest’opera di Louis A. de Furia è effettivamente un tentativo riuscito di risuscitare persone, fatti e posti di cui nessuno prima aveva scritto in modo impegnativo. Sinora non era possibile neanche pensare che fossero mai esistiti. Nessuno aveva mai considerato quelle persone, fatti e luoghi – e questo è preoccupante – come materiale degno di narrativa, sia nella nostra Irpinia che in quella piccola comunità americana che fa risalire le proprie origini sino a una sconosciuta e montuosa zona del Sud d’Italia… Grazie a Dio esistono ancora in Irpinia le fonti della tradizione orale: canzoni e racconti del folklore, credenze religiose e superstizioni, oltre che storie di famiglia ben documentate. Sono questi gli elementi che il cugino Luigi ha amalgamato meravigliosamente insieme. Ecco qui un romanzo storico in cui persone e fatti, che altri scrittori disdegnano, assumono vita miracolosamente, apparendoci memorabili e degni di affetto. E, al mio orecchio di italiano, questa prosa, e specialmente il giro delle frasi (anche se in inglese e riportate in forma di discorso indiretto dei vari personaggi) evocano il modo di parlare dei miei genitori, dei vicini di casa e degli amici perduti. In breve, tutte le particolarità linguistiche della mia terra d’origine, dove il dialetto viene ancora parlato quando uno vuole esprimere affezione e amicizia. [Continua] [Nativo]
[Ed. 00/06/2003] Quest’opera di Louis A. de Furia è effettivamente un tentativo riuscito di risuscitare persone, fatti e posti di cui nessuno prima aveva scritto in modo impegnativo. Sinora non era possibile neanche pensare che fossero mai esistiti. Nessuno aveva mai considerato quelle persone, fatti e luoghi – e questo è preoccupante – come materiale degno di narrativa, sia nella nostra Irpinia che in quella piccola comunità americana che fa risalire le proprie origini sino a una sconosciuta e montuosa zona del Sud d’Italia… Grazie a Dio esistono ancora in Irpinia le fonti della tradizione orale: canzoni e racconti del folklore, credenze religiose e superstizioni, oltre che storie di famiglia ben documentate. Sono questi gli elementi che il cugino Luigi ha amalgamato meravigliosamente insieme. Ecco qui un romanzo storico in cui persone e fatti, che altri scrittori disdegnano, assumono vita miracolosamente, apparendoci memorabili e degni di affetto. E, al mio orecchio di italiano, questa prosa, e specialmente il giro delle frasi (anche se in inglese e riportate in forma di discorso indiretto dei vari personaggi) evocano il modo di parlare dei miei genitori, dei vicini di casa e degli amici perduti. In breve, tutte le particolarità linguistiche della mia terra d’origine, dove il dialetto viene ancora parlato quando uno vuole esprimere affezione e amicizia. [Continua] [Nativo]
Mario Sorrentino
THE ROAD FROM ARIANO IRPINO
Brani scelti e tradotti a cura di M. Sorrentino
Introduzione (pp. 3-4)
La parte più consistente della presente narrazione deriva da uno scritto di mio padre, Alfonso De Furia, che si sforzò di raccogliere sotto forma di cronaca storie udite da ragazzo. Le aveva raccolte per iscritto quando era un immigrato ancora fresco, relativamente parlando, qui in America. Avendo perso il padre da poco, fu preso dal timore che la componente italiana della nostra storia potesse andare perduta per le generazioni che sarebbero nate qui, in un’America che poteva diventare un nuovo enigma per loro.La cosa che agì da stimolo su di lui, nell’estate del 1934, fu una mostra di macchine da scrivere Underwood che vide ad Atlantic City, New Jersey, durante una vacanza poco dispendiosa (erano i tempi della Depressione) trascorsa in quella città con la famiglia. Stavano a pensione presso un compaesano che viveva lì e il loro massimo divertimento di villeggianti era godere dei suoni e del vivace movimento della passeggiata a mare, tutto totalmente gratis. In una vetrina dell’Hotel Resort che guardava sul lungomare c’era in mostra un modello di macchina da scrivere gigante, alta più di tre metri e mezzo, se la memoria non fa scherzi, la quale era collegata a una tastiera a distanza posta su una scrivania. Quel mostro scintillante, nichelato e nero di lucido smalto, catturò e infiammò la sua immaginazione. Guardava a bocca aperta la macchina mentre stampava lettere alte venti o venticinque centimetri, e gli sembrò di aver trovato la soluzione di cui aveva bisogno per completare rapidamente e efficientemente la cronaca di famiglia. Acquistò una portatile, accampando poi timidamente la scusa con mia madre (la quale portava in grembo da quattro mesi colui che sarebbe diventato il terzo figlio) che, insomma, sarebbe stato molto utile ai figli imparare a scrivere a macchina. Iniziò così a scrivere ciò che state per leggere, la storia di Placido, battendo i tasti con due sole dita, nel dialetto del suo paese.
Capitolo Secondo (pp. 27-31)
Portava sottobraccio un malloppo di vestiario: una camicia, dei fazzoletti, calze e un paio di calzoni da mettere la domenica. Appeso all’altro braccio reggeva una cassetta con gli attrezzi del mestiere, attrezzi da falegname appartenuti a suo padre. Erano pochi e costituivano la porzione che gli era toccata quando avevano diviso l’eredità con i fratelli. Erano stati fatti da suo padre, Liborio, usando legni duri locali come il durame di noce che, se stagionato, è più duro del ferro. Quando il padre rimaneva soddisfatto della forma dell’attrezzo (perché un vero ‘masto’ si preoccupa sia del suo aspetto estetico che della funzionalità) lo portava alla ferramenta Lanza, ordinava lame d’acciaio di tempra e lo completava. In questo modo si era fatta una grande varietà di pialle, dalle sponderuole per lavori di modanatura, alle pialle più grandi per lisciare tavole. Placido ci stava attento a questo suo patrimonio, perché sapeva quanta fatica erano costati a suo padre. Sostituirli sarebbe stato difficoltoso e anche costoso.
Giunto alla Madonna dell’Abbondanza, alla periferia della città, voltò e cominciò a scendere per Via di Monte Carmelo, una scorciatoia che portava in campagna. In meno di cento metri, arrivò a un incrocio dov’era la fontana pubblica detta “Fontana della Tetta”, che – alla lettera – significa appunto “della mammella”. Alla fontana era stato dato quel nome per la credenza che la sua acqua facesse bene alle mamme che allattavano. Forse nell’acqua era presente in sospensione un qualche nutriente naturale. Gli arianesi, inoltre, pensavano che bere alla fontana portasse fortuna. L’acqua proveniva da una sorgente che era in alto, sulla montagna, e veniva incanalata verso una cisterna per mezzo di una tubatura di terracotta impiantata secoli prima da contadini longobardi.
Si fermò e con un sospiro di sollievo, dopo aver salutato con cenni del capo alcune donne venute a prendere acqua, posò a terra il suo bagaglio che stava diventando già pesante. Staccò il mestolo di rame battuto dall’uncino di ferro lavorato, lo tenne sotto il getto dell’acqua per riempirlo e bevve.
Placido sapeva che quella era l’ultima fontana che avrebbe trovato lasciando Ariano…
Salutò con un cenno del capo le donne venute a prendere acqua e riprese il cammino. Nessuna di loro aveva dato mostra di accorgersi del saluto, ma lui sapeva che non doveva aspettarselo. L’etichetta sociale disapprovava un tale segno di familiarità in una donna.
Capitolo Terzo (pp. 37-38)
Fedele Tedesco era un mastro falegname di Montecalvo. Era molto apprezzato nel paese e nei dintorni per la sua bravura: non solo faceva infissi – porte e finestre – ma godeva anche di una ben meritata reputazione come mobiliere raffinato. Del resto, faceva qualunque tipo di lavoro con buona volontà per sostenere la famiglia. Spaziava perciò dalle arnie per le api ai mobili di lusso finemente intagliati. E andava fiero non poco del suo lavoro.
Sfortunatamente era privo di senso dell’umorismo: la vita per lui era una faccenda seria. Sorrideva raramente, eccetto che a sua figlia Marantonia. Quando lavorando ne udiva la voce, mentre di là lei rideva insieme alla madre, gli sfuggiva un sorriso che svelava quale fosse l’affetto per quella figlia. E se la guardava gli si illuminava il volto.
Uno dei racconti su di lui, che veniva ripetuto ogni volta che veniva fuori il suo nome in un discorso, era quello dell’albero di castagno che aveva comprato “sull’unghia”, per dir così. Il proprietario voleva sbarazzarsi dell’albero e lui ne aveva contrattato l’acquisto quando la pianta stava ancora ritta sulle radici. Il prezzo pagato da Fedele era stato veramente irrisorio – poche lire, tutt’al più – poiché sapeva che avrebbe dovuto abbatterlo e trasportarselo a casa, prima di poter pensare a qualsiasi guadagno sul suo investimento.
Si diceva, invece, forse esagerando un po’ come avviene di solito nelle leggende, che fosse vissuto su quello che gli apportò l’albero un anno intero. Dai rami più sottili, che divisi in strisce gli servirono per farne canestri, alle tavole piallate per mobili, tutto venne usato. Il suo investimento fruttò al massimo e allo stesso tempo – chi l’avrebbe detto? – servì ad arricchire con una nuova storia il folklore paesano. “Masto” non era un vuoto titolo d’onore nei saluti che gli venivano indirizzati.
Non avendo figli maschi aveva accettato un apprendista nella sua bottega. Gli avrebbe insegnato tutte le finezze del mestiere facendolo lavorare con lui. Placido, il nuovo apprendista, non aveva vincoli di sangue con la famiglia Tedesco, ma era un parente acquisito per matrimonio, perciò l’uso di “zio” da parte del giovane verso Fedele.
Fedele, lavoratore instancabile, aveva appreso il mestiere dal padre insieme al fratello Domenico. Il mestiere costituiva un’eredità che equivaleva ai soldi o alla proprietà. C’era una “piccola” differenza tra i due fratelli, c’è da dire. Diligente l’uno: Fedele; indolente l’altro. L’allegro Domenico era un buon mastro d’ascia, ma era più attirato dalle carte da gioco e dai divertimenti che dal lavoro. Possiamo dire che se gli offrivano uno o due bicchieri di vino non li rifiutava mai? Non era da lui offendere con un rifiuto un padrone di casa ospitale. Fedele riteneva riprovevoli tali bizzarrie e giudicava Domenico capriccioso e scialacquatore. Ciò nonostante quel birbante di Domenico riusciva simpatico a tutti perché era socievole e amicone, al contrario del fratello che era riservato.
La figlia di zi’ Fedele, Mariantonia, era un bocciolo di gioventù. Tutti quelli che la vedevano, anche gli estranei, ne erano affascinati. Ma lei, per l’eccessiva modestia, era totalmente ignara degli effetti che produceva sugli altri.
Capitolo Settimo (pp. 102-105)
Fu alcuni anni dopo che Placido ebbe aperto lo spaccio di generi alimentari che i lavoratori della nuova ferrovia raggiunsero i confini comunali, giù nella valle. Una buona occasione, ci si sarebbe potuto aspettare: quell’afflusso di operai affamati offriva una possibilità di guadagno a Placido.
Gli operai della ferrovia, eccetto pochi settentrionali, erano per la maggior parte lavoratori reclutati nei dintorni di Napoli, o per via, a mano a mano che avanzava il tracciato. In mezzo a loro, un miscuglio poliglotta di contrabbandieri italiani e francesi, tedeschi giramondo e vagabondi austriaci, socialisti e briganti in fuga dalla legge. Anche contadini, avventurieri, i soliti giocatori d’azzardo e la gente strana che segue i cantieri. Le squadre lavoravano nella zona detta ‘la Cristina’, e gli operai erano ormai belli e stanchi dei venditori ambulanti, infidi come zingari, che li seguivano per vendergli le cose di cui avevano bisogno. Ed erano nauseati del pane ammuffito e stantio, delle zuppe scotte e oleose, mischiate con frattaglie immangiabili e scarti di carne grassa nelle marmitte della ditta.
Gli operai cominciarono a salire al paese per comprare roba da mangiare. Volevano roba decente, ma a credito. Perché a credito? Perché l’appaltatore, un certo signor Melisurgo, per contratto avrebbe dovuto pagare gli operai ogni quindici giorni, ma una volta sì, una volta no, il giorno di paga cambiava. Cambiava in base al capriccio dei burocrati dell’ufficio amministrativo, ragionieri e cassieri, così rapaci come solo sanno esserlo dei subordinati dalla mente meschina che si ritrovano con un po’ di potere tra le mani. Erano questi impiegati completamente succubi delle lusinghe e dell’opera di corruzione degli amministratori dei comuni posti lungo il tracciato. Presi dall’ansia che gli operai potessero non spendere le loro paghe nelle cantine e negli altri negozi del proprio paese, questi amministratori corrompevano i cassieri della ditta affinché rimandassero o anticipassero i pagamenti agli operai (a seconda che i cantieri stessero per entrare o per andar via dai loro territori)(1)
Per quanto favorevole potesse sembrare la loro presenza, in tutta onestà, nessuno, eccetto ovviamente gli ingenui, avrebbe potuto considerare quegli uomini, che si spostavano continuamente per deporre i binari lungo il tracciato, gente di cui fidarsi al punto di fargli credito. Si trattava di un branco di rozzi manovali che si rinnovava continuamente. Erano abituati a dormire nei carri ferroviari su giacigli di paglia. E molti dormivano addirittura sotto le stelle, coperti da stracci e sulla paglia pure loro. Dormivano con la pala e il piccone a fianco, perché se li perdevano glieli addebitavano sulla paga. Alcuni di loro più fortunati, lavoratori specializzati dell’Alta Italia, per lo più, erano alloggiati nell’ospedale dell’Annunziata.
Placido aveva clienti tra gli operai. Quell’impresa straordinaria della ferrovia, pensava, poteva essere una buona opportunità per il suo spaccio. Fu sedotto e si convinse, dopo qualche riluttanza, a dar via la roba a credito. Gli operai promettevano, giuravano che avrebbero pagato scrupolosamente – “per la Madonna”, quando a loro volta fossero stati pagati dai capi. Placido veniva dunque continuamente rassicurato che avrebbe ricevuto i suoi soldi. Sapeva di correre dei rischi, ma quando si sarebbe più presentata una possibilità come quella per migliorare la propria sorte? Quante altre ferrovie sarebbero mai arrivate da quelle parti? Era sicuro che la Provvidenza gli stesse sorridendo, perciò fece la scommessa che avrebbe avuto fortuna.
Passò del tempo ma, per la verità, di pagamenti di qualche importanza neanche l’ombra: Placido non incassò se non complimenti e promesse. I lavori della ferrovia si spostavano in avanti, sempre più lontano dal territorio comunale, e gli operai continuavano a promettere che avrebbero pagato. Alcuni ancora tornavano alla fine della giornata di lavoro, un lungo e arduo viaggio a piedi su per la montagna, per mangiare qualcosa e poi bighellonare nelle piazze del paese. Quando finalmente gli operai vennero pagati, si trovavano però già a Pianerottolo, fuori del territorio montecalvese. I clienti di Placido, naturalmente, si erano spostati insieme al loro cantiere, che era quello di testa.
Dopo aver aspettato pazientemente un bel pezzetto senza ricevere neanche un soldo, su insistenza di Anna, sua moglie, Placido andò a cercare gli operai per farsi pagare. Portò con sé il figlio Gaetano, allora soltanto un ragazzino. I fornitori dello spaccio stavano diventando nervosi e minacciavano denunce. Placido si sentiva perciò obbligato a partire e tentare di incassare: non aveva scelta. Andarono al cantiere, il padre con la lista dei debitori in mano. Si misero a cercare facce conosciute nella folla degli operai. Prima però Placido aveva chiesto il permesso al padrone del cantiere, il quale per tutta risposta aveva detto con tono sprezzante: “Accomodati pure!” Non era nuova quella storia per l’appaltatore: a partire da Napoli, si era ripetuta quasi in ogni posto in cui il cantiere era passato.
Placido aveva tenuto la sua lista aggiornata, con tutti i nomi e i crediti scritti con cura. Una cosa priva di senso, perché la stragrande maggioranza degli operai non sapeva leggere niente, figurarsi un conto. Sapevano soltanto firmare con un segno di croce. Era una cosa stupefacente come certi scarabocchi e segni di croce somigliassero a tanti altri, ingenerando dubbi sia nel venditore che nel cliente. I conti che Placido mostrava venivano negati con veemenza. E si spaventò quando alcuni operai gli chiesero quanti dei suoi ex clienti della lista erano già morti, o magari rientrati a casa gravemente ammalati, mentre il cantiere, fatti i bagagli, si era spostato.
Altri li salutavano con urli di “Ué” o con fischi, per mettere in guardia altri bei tomi pari loro che lavoravano più avanti lungo i binari. Molti negavano il debito, se mai si riusciva a scovarli dopo che erano stati preavvertiti. Lo negavano con una bugia già sperimentata, rispondendo che neanche sapevano dov’era Montecalvo, figurarsi il suo negozio. Così maltrattati, padre e figlio alla fine non sapevano che altro fare – come se ci fosse una qualsiasi cosa che potessero fare. Dopo l’irrisione con cui i pagamenti erano stati negati, il clima si stava facendo brutto veramente. Se Placido e il figlio non se la fossero data a gambe alla svelta, certamente la folla minacciosa li avrebbe massacrati di botte volentieri, come ricompensa per la loro ingenuità.
Capitolo Nono (pp. 147-150)
Il ragazzo non ignorava che “l’abbandonato” del paese, di cui si mormorava che fosse un prete scomunicato, era fratello di suo padre. Aveva visto per anni quel vecchio sedere in piazza a scaldarsi al sole, oppure mentre andava in giro, ma non aveva mai udito qualcuno parlare di lui o sentito dire che era suo zio. Ad ogni modo egli sapeva che quell’uomo era uno dei fratelli di suo padre. Era un uomo di piccola statura che incuteva un certo timore. Una volta l’aveva fissato per un attimo come se lo riconoscesse, ma era stato solo un lampo negli occhi del vecchio. Occhi che per l’età, la vita dissipata erano diventati spenti e avevano perso vivacità. Gaetano era fiero di portare il nome di un altro zio prete, un prelato molto riverito, di cui suo padre parlava continuamente. Il ragazzo era mortificato di non sapere dedicare neanche un angolino della sua mente a quell’alcolizzato, a quell’uomo abbrutito. Per carità, visto che tutti l’aborrivano in paese. Ma Gaetano non aveva molto tempo per mettersi a pensare a quell’uomo strano.
Mandato una volta da sua madre – la compassionevole Anna – Gaetano portò al municipio dei vecchi panni da dare a Liberatore. Si trattava dei vestiti appartenuti a un vicino di casa passato a miglior vita che lei pensava potessero andar bene al vecchio. Le donne compassionevoli comprendono quali sono le forze e gli istinti che possono abbrutire un uomo. E sono tolleranti verso chi li subisce, anche se moralmente considerano quelle forze e quegli istinti aberranti. Più tolleranti degli uomini, ad ogni modo. La ragione forse dipende da qualcosa presente nel patrimonio genetico delle donne. Comunque, la roba portata al comune da Gaetano era così lisa che poteva essere difficilmente indossata, ma allora i vestiti venivano portati finché non si lacerava l’ultima fibra.
In quell’occasione capitò che i due s’incontrassero. La cosa li colse entrambi di sorpresa. Gaetano in seguito cercò di ricordare se lo zio fosse veramente così basso, o se non fosse piuttosto piegato dai reumatismi.
Il ragazzo non s’era trattenuto abbastanza a lungo da poter ricordare bene l’incontro. Aveva deposto il pacco a terra vicino a Liberatore, lì nell’atrio del municipio. Solo più tardi ricordò che aveva provato un senso di paura, di cui non sapeva spiegarsi il motivo. Più tardi capì che quel sentimento era ingiustificato e che il vecchio non avrebbe potuto né voluto far del male a nessuno. Si era girato per andar via, dopo un attimo d’esitazione, quando sentì pronunciare il suo nome: “Gaetano”. Doveva essere stato Liberatore. Ma Gaetano non ne fu mai certo. Echeggiava qualcosa nel tono di quella voce: una domanda? un’affermazione? un lamento? Non riusciva a decidersi tra queste tre possibilità, quando più tardi suo padre l’interrogò. Dopo qualche tempo dubitò di aver mai udito il nome. Aveva forse il vecchio riconosciuto nei lineamenti del ragazzo qualcosa che per un istante straordinario aveva riportato alla luce un ricordo del suo passato? Si può immaginare con quanta dolcezza sarà risuonato quel nome sulle labbra di Liberatore? Il sensibile Gaetano non dimenticò mai quell’incontro casuale. Il suo ricordo lo accompagnò tutta la vita.
Alla fine, la triste storia di Liberatore gli fu svelata. Anna fu costretta a rivelargli il passato travagliato del prete, tanto incalzanti erano diventate le domande del ragazzo. Suo padre, gli fece capire la madre, si vergognava di essere parente di uno che non poteva essere redento nel modo più assoluto. Un “ubriacone dimenticato da Dio”, diceva il padre. Ma si sbagliava: Dio non abbandonò mai Liberatore. E siamo sicuri che anche Liberatore lo pensava. Come possiamo sapere una cosa simile? Be’, perché quando fu trovato morto stringeva nella sua mano esile il rosario. Un rosario fatto di noccioli di olive che provenivano, come si diceva, da un ulivo del Getsemani. Era un segno certo che egli si considerava ancora un cristiano, anche se indegno agli occhi degli altri. C’era poi un altro segno… esito a parlarne, però sulla pelle rinsecchita e tesa della fronte di Liberatore era graffiato il segno della croce. Chi poteva averlo tracciato se non il prete in persona? Che cosa voleva esprimere con quel segno?
Toccò a Gaetano portare a seppellire Liberatore, con un carretto e un cavallo presi a prestito. Pure a prestito era il becchino comunale che se ne stava seduto sul carretto accanto al cadavere piccolino di Liberatore avvolto nel sudario. Del lusso di una bara di legno di pino, neanche a pensarci. I due erano tutto il corteo che presenziò al triste rito finale del prete scomunicato. Lo portarono al cimitero e lo seppellirono in una fossa anonima. Né una croce né una lapide distinguevano la fossa. Niente di niente. Non piantarono nella terra soffice appena scavata neanche un ramo strappato da qualche siepe vicina, in commemorazione del defunto.
Quando ebbero finito e Liberatore se ne stava al sicuro nell’abbraccio della madre terra, il ragazzo fu sopraffatto all’improvviso dalla compassione. Sentiva di dover fare qualcosa, magari raccogliere un po’ di fiori selvatici, di boccioli di trifoglio, o anche dell’erba tenera da deporre sul tumulo. Esitò e non ne fece niente, temendo una qualche parola beffarda del becchino impaziente. Il degno lavoratore voleva andarsene subito e brontolava: “Ci ho guadagnato una miseria con questo lavoro. Solo tempo sprecato per un cadavere che non se lo merita”.
Capitolo Undicesimo (177-180)
Masto Gaetano fu nominato postino capo di tre comuni nel 1880. Era l’unico ufficiale postale di Montecalvo, Casalbore e Sant’Arcangelo Trimonte. Restò in servizio cinquantadue anni, il più lungo servizio che si registrasse a quei tempi, un record di cui egli andava fiero…
Un biroccio(2) tirato da due cavalli, che giungevano spossati sulla sommità, portava giornalmente la posta dal deposito ferroviario, che era giù nella valle. Condotti con un atteggiamento di studiata importanza dal birocciaio, i cavalli passavano sotto lo sguardo annoiato dei vecchi perdigiorno della piazza, i quali, giudicando dal fatto che i cavalli fossero o meno sudati, concludevano, nel primo caso: “Deve essersi fermato da qualche parte ”. Non sbagliamo a dire che l’arrivo del carro postale era un avvenimento importante, all’epoca. Una volta giunto su terreno piano, il conducente metteva al passo i due cavalli che sbuffavano e attraversava così la piazza sino all’ufficio postale.
L’ufficio postale, a quel tempo, era ricavato in una stanza di sasso che si affacciava sulla piazza che (oggi) è detta di San Pompilio M. Pirrotti. Lo spazio era stato recuperato dal vecchio Ospedale di Santa Caterina. La piccola stanza era stata in altri tempi una specie di atrio presidiato da monaci e monache, che vi facevano una cernita rudimentale degli ammalati da ricoverare. Sfortunatamente l’ospedale era stato già distrutto molti anni prima da un terremoto che aveva devastato gran parte del paese.
Dopo aver fermato il suo biroccio davanti all’ufficio postale, il conducente scendeva e stringeva la martinicca per evitare che i cavalli si sviassero. Una precauzione necessaria che lo faceva imprecare in più di un’occasione. Era convinto che gli animali diventassero nervosi perché venivano disturbati dai lamenti e mormorii degli spiriti che, secondo lui, abitavano nell’antico edificio. Forse era vero, ma Gaetano, stanco di sentire sempre questa storia, insisteva a spiegare che era il vento il quale, risalendo su per le pendici della montagna, s’infiltrava tra le crepe e le lesioni nei vecchi muri di sasso dell’edificio e faceva quei suoni strani. Il birocciaio non voleva saperne di una spiegazione tanto semplice, sapeva lui quello che sapeva, del resto egli credeva nelle capacità extra sensoriali dei suoi cavalli.
L’uomo consegnava il sacco della posta e Gaetano firmava il modulo di ricevimento. A quel punto, dopo aver firmato il registro giornaliero dell’ufficio, il birocciaio prendeva la posta in partenza e la metteva nell’apposito sacco. Su entrambi i sacchi era stampato lo stemma del Regno d’Italia.
L’uomo parlava abitualmente con i suoi cavalli. Gli prometteva il meritato riposo giù alla stazione. Sempre le stesse chiacchiere che sembravano avere un effetto calmante sulle bestie. Il viaggio di ritorno alla stazione cominciava dopo aver abbeverato i cavalli alla fontana. L’uomo si serviva del secchio appeso dietro al biroccio, ma, cosa divertente, nell’abbeverarli doveva ricordare quale dei due era stato il primo all’ultima abbeverata. Se scombinava il turno, il cavallo che subiva il torto rovesciava con un calcio il secchio pieno d’acqua, impedendo così al compagno di bere. Il secchio veniva riempito di nuovo e il cavallo beveva indisturbato, mentre l’altro se ne stava tranquillo ad aspettare il turno. Il birocciaio se la godeva un mondo a questa sceneggiata, facendo finta di rimproverare la bestia che aveva rovesciato il secchio per il divertimento di eventuali spettatori. Avrebbe potuto portarsi dietro due secchi, ma se l’avesse fatto, nessuno avrebbe saputo quanto erano intelligenti i suoi animali…
Masto Gaetano portava il sacco sigillato nella sua arcaica sede e, dopo averlo aperto, cominciava immediatamente a fare la cernita, disponendo le lettere per zone, poi in base alle vie e infine ai numeri civici, in modo che la posta, i giornali ecc. potessero essere distribuiti il più presto possibile. Alcuni degli anziani della piazza ricevevano regolarmente rimesse dai loro figli emigrati. Spesso la busta conteneva soltanto il vaglia. Raramente nello spazio apposito vi erano altre parole oltre a “Tanti baci”, magari scritte dall’impiegato che aveva emesso il vaglia. E che sarebbero state lette al destinatario dal portalettere. Occasionalmente nella busta c’era una fotografia, allora era una vera festa.
Intanto, il gruppo abituale dei perdigiorno della piazza se ne stava in piedi, davanti all’ufficio, a discutere di politica o a scambiarsi gli ultimi pettegolezzi del paese, insomma a sparlare di gusto, aspettando la posta. Non per questo rinunciavano ad esprimere giudizi estetici su una qualche ragazza carina abbastanza temeraria da passare di là. Erano sempre gli stessi, un gruppo che non cambiava mai. Aspettavano e non appena il portalettere apriva il suo sportello, subito cominciavano a chiedergli: “Niente per me?” “Qualcosa per me?”. Gaetano, con grande pazienza, cercava di soddisfare tutte quelle richieste che si accavallavano. La loro impazienza, del resto, alleggeriva in fretta il mucchio di lettere da distribuire. Alcuni ci rimanevano male, se non c’era posta per loro. Gaetano ne conosceva alcuni che non avevano ricevuto posta da anni. Si chiedeva perplesso che cosa mai stessero aspettando: quale parente partito da tempo doveva farsi vivo? Quale fortuna fantasticata nella mente doveva materializzarsi per posta?
Prima di allontanarsi dall’ufficio, Gaetano chiudeva la porta e lo sportello che dava sulla piazza. Si faceva largo in mezzo a quelli che ancora restavano davanti all’ufficio e attaccava con i chiodini, sulla tabella di legno fissata a lato dell’ingresso, gli avvisi del governo, se ne erano arrivati. Poi iniziava il giro della piazza: era la prima zona a essere servita. Si fermava davanti alle case che vi si affacciavano, scambiando chiacchiere e consegnando lettere. Prometteva di tornare, per leggere la posta o preparare le lettere di risposta, per quelli che non sapevano leggere e scrivere. Si sentiva nel proprio elemento.
Capitolo Undicesimo (183-186)
Come sagrestano Gaetano assisteva l’anziano don Ciccio, un amico che conosceva e amava da una vita. Il prete era diventato parroco di San Sebastiano quand’era giovane e lì rimase per tutta la sua carriera di prete. Lui e il padre di Gaetano, Placido, erano venuti in paese più o meno alla stessa epoca. Era stato don Ciccio a dare un’educazione scolastica a Gaetano, da bambino e da ragazzo. E Gaetano assisté don Ciccio all’altare per diciannove anni, da buon cattolico qual era.
Un’altra attività di Gaetano, come se non avesse abbastanza da fare con le altre, era la compravendita di vino. Sua moglie Vittoria, una donna che dovette sopportarlo una vita, giurava che ne beveva più di quanto ne vendeva. E le piaceva ripetere, scherzando soltanto a metà, che la vita del marito si svolgeva tra Dio e il diavolo: la cantina più vicina (che era poi della sorella di lui, Serafina) si trovava infatti in una stradina giusto dietro la chiesa di San Sebastiano.
Il risultato di una giornata di assaggi molto generosi di vino fu che Gaetano si sentiva un po’ fuori fase servendo a vespro. Dopo le solite preghiere e il responsorio davanti al Santo Sacramento, nel momento in cui doveva raggiungere don Ciccio sull’altare e mettergli la pianeta sulle spalle… se ne andò. Infilò la porta e via. Piantò il prete che stava sull’altare con le mani alzate in attesa del paramento, dando le spalle alla piccola congregazione. A un certo punto, confuso, don Ciccio si girò e subito si mise a chiamare: “Gaetano… GAETANO!” Ma Gaetano non c’era. Don Ciccio raccolse allora la pianeta, se la mise da solo sulle spalle e finì in fretta e furia la cerimonia. Volò fuori della chiesa e attraversò di corsa la piazza sino alla casa di Gaetano. L’indignazione gli gonfiava il petto. Voleva una spiegazione per quel comportamento irrispettoso. Una bella ramanzina si meritava. Ma Gaetano non era a casa, lì non s’era visto. La paziente Vittoria sospettava che c’entrasse il vino. Comunque, pensava che non spettasse a lei scusare il marito. Don Ciccio lo conosceva altrettanto bene, e certamente da più lungo tempo.
Seguì il prete in chiesa per cercare Gaetano, pensando che il marito fosse andato a dormire nella cappella della Madonna del Carmine. Il prete aveva messo nella cappella un banco molto comodo per l’uso dei pellegrini e dei parrocchiani. Lì uno poteva sedere e meditare nella solitudine e nella quiete. E se ne sentiva il bisogno, poteva sdraiarsi sotto lo sguardo protettivo della Madonna e dormire. Il prete non ne avrebbe saputo niente. Ma neanche la Madonna aveva visto Gaetano. I due continuarono a cercarlo in tutti gli angoli della chiesa. Cercarono con attenzione, ma non lo trovarono. La chiesa non era così grande da non poterlo scoprire, se fosse stato lì dentro.
Vittoria spedì il figlio Alfonso a cercarlo nelle cantine. Il prete lo avvertì: “Non tornare senza di lui!” Ma nessuno aveva visto il postino. Il ragazzo rimase fuori fin quasi a mezzanotte, chiedendo a tutti quelli che incontrava: “Avete visto Gaetano, il portalettere?” Nessuno l’aveva visto, Gaetano non si trovava da nessuna parte. Alfonso tornò esausto e sconvolto dall’inquietudine e alla madre disse: “Non riesco a trovare papà, nessuno l’ha visto.” Don Ciccio, che non era rimasto ad aspettare il ritorno del ragazzo, era convinto che la terra gli si fosse aperta sotto i piedi, a quel furfante, e Satana se lo fosse portato via. “Gli starebbe bene, sarebbe una lezione ben meritata,” mormorava, mentre si segnava con il segno di croce. Era frustrato per non poter sfogare la sua rabbia sulla zucca di quel miscredente in fuga.
La povera moglie sentiva il cuore mancarle e non sapeva che fare. Nella sua mente prendeva forma ogni specie di disgrazia. Poteva essere andato a consegnare una lettera lontano? No, l’avrebbe avvertita. Un comportamento simile non era da Gaetano, che era molto abitudinario.
Si abbandonò a questo punto con tutte le sue paure alla preghiera.
Stanca e piena di apprensioni, alla fine si ritira a casa. Mentre sta sdraiata sul letto, senza poter prendere sonno, Vittoria sente prima uno sbuffo poi un distinto russare. Sobbalza. Si mette a cercare nella stanza per scoprire da dove provengono quei rumori. Alla fine scopre che Gaetano giace addormentato nella cassa da morto. Cassa da morto? Quale cassa da morto? Torniamo indietro
(1)La frase tra parentesi è stata aggiunta dal traduttore per chiarire il meccanismo della corruzione.
(2)Una varietà del traìno, ma più corto e dotato di cassetta coperta per il conducente.
Louis A. de Furia
Appendice (pp. 81-88)
Nascostasi nei pressi della casa, la vecchia trovò modo di intrufolarsi tra gli invitati alla festa di nozze. Si chiamava Benigna, che vuol dire “benevola”. Un nome in stridente contrasto con il ruolo da lei svolto in ciò che raccontiamo. L’odiosa arpia non era stata invitata. I compaesani la evitavano e per fondate ragioni, come si vedrà.
Approfittando dell’allegria generale cominciò ad assaggiare il cibo e di preferenza a bere l’ottimo vino offerto dal padre della sposa, che se ne intendeva perché ne faceva commercio. Il vino buono era una prelibatezza per lei che, misera com’era, non poteva certo permetterselo.
Era una donna con una bella faccia tosta, una vera faccia di bronzo. Si presentava a ogni sposalizio, o ad ogni altra occasione di festa dove potesse infilarsi fra gli invitati specialmente se questi erano numerosi. Nello sposalizio di Anna e Placido andava ripetendo a chi voleva ascoltarla: “Questo matrimonio fa grande onore a Placido l’arianese.” Sapeva e contava sul fatto che nessuno, in una così felice circostanza, avrebbe trovato nulla a ridire sulla sua presenza. Sfortunatamente Benigna si trovava lì per ben altro che mangiare e bere. La vecchia era stata pagata perché con la sua zampina di gatta traditrice colpisse gli sposi con un maleficio.
La strega agiva per conto di Mariantonia Tedesco, l’innamorata abbandonata da Placido. Ora aspettava e spiava tenendosi sul limitare del gruppo dei festaioli, tutta intenta a bere con fare innocente per non attirare l’attenzione su di sé. Poi si fece sotto alla sposa con la cautela della belva che sta per assalire la preda. Scelse il momento giusto.
A turno tutti cominciarono a proporre brindisi agli sposi gridando e tracannando il buon vino. Lei intanto versò di nascosto in un bicchiere già colmo qualcosa. Poi con fare scherzoso propose anche lei un brindisi alla sposa, facendosi ascoltare con la sua voce stridula nel frastuono generale. Un brindisi che la sposina poteva forse rifiutare? “Alla salute di Placido e auguri a te e a lui per tanti figli maschi!” Anna, incoraggiata e circondata dagli inconsapevoli invitati, che avevano tutti levato in alto i loro bicchieri, vuotò il bicchiere che le aveva dato Benigna in un sorso solo.
Benigna tentò la stessa manovra con Placido ma non le si offerse l’occasione… quando però alcuni invitati cominciarono a lanciare coriandoli e confetti, s’avvicinò allo sposo e gli versò sul vestito il resto della pozione maligna…
La mattina seguente i parenti e gli amici venuti da Ariano partirono e la madre di Placido con loro. Di modo che fu la sola madre di Anna a recarsi alla casa degli sposi per la visita di rito. (Un rito che non veniva specificato ma che tutti conoscevano perché avrebbe attestato l’illibatezza prematrimoniale della sposa – NDT). La signora Maria ci andava con la scusa di portare ai due giovani il caffè.
La casa era appena fuori della piazza, su per Via Monte. La donna camminava reggendo la cuccuma del caffè avvolta in un panno di cucina. Era ricolma di gioia e sentendo il caldo della caffettiera anticipava col pensiero il piacere di condividere la colazione con gli sposini.
Raggiunta la casa, Maria bussò piano per non attirare l’attenzione di eventuali passanti. Strano, ma non ottenne risposta dall’interno. Sapeva che la casa era troppo piccola perché non avessero sentito. Aspettò un momento e bussò di nuovo un pochino più forte e una terza volta più forte ancora; ma sempre silenzio. In piedi sullo scalino d’ingresso si guardò intorno perplessa. Forse i due si erano alzati presto e andati a fare una passeggiata…
Stringendo l’involto del caffè ancora caldo sul petto, Maria si diresse a casa sua. Camminava con passo lento sentendosi addosso gli sguardi dei vicini del rione. E immaginava ogni sorta di cose. Erano usciti per voglia di stare soli da qualche parte?…
Don Antonio Di Florio, padre della sposa, accettò di andare con la moglie a vedere che cosa fosse successo: era scocciato di aver dovuto interrompere il suo lavoro e sentirsi costretto a occuparsi di una faccenda riservata alla moglie. Sulla via del ritorno lei dovette sopportare i brontolii del suo uomo che se la prendeva con la gente che li guardava passare. Gente che si impicciava degli affari degli altri. Lui era sicuro che si trattava di una perdita di tempo. Potevano essere andati a ricambiare una visita agli amici (egli stesso non ci credeva mentre lo diceva); o essere andati a pregare in chiesa, ecc. Erano molte le ragioni che potevano averli fatti uscire di casa.
Arrivati lì, bussarono una volta, due volte, ma sempre senza ricevere risposta. Ora erano in due a non sapere che fare. Soprattutto non volevano attirare la curiosità dei vicini. Comunque, era già tardi perché già alcuni di loro stavano fermi impalati a guardare.
All’improvviso si sentirono rumori e urli soffocati provenire dall’interno della casa. Don Antonio molto preoccupato forzò allora la porta ed entrarono. Il caos totale regnava in quella che prima era stata una casina carina e confortevole. I pochi mobili erano buttati per terra; la sposa teneva alta una scopa e lui un bastone: e ad intervalli tentavano di colpirsi. I genitori, dall’angolo dove s’erano rifugiati, chiedevano inutilmente: “Che cos’è che non va?”. Ma nessuno dei due rispondeva, intenti com’erano a tentare di darsele. Indossavano ancora tutti sgualciti i vestiti di nozze. Il padre e la madre alla fine si convinsero che la lite fosse scoppiate per vanterie di schiatta o d’onore (quegli arianesi con la puzza sotto il naso, e magari poteva entrarci l’onore della sposa, chi poteva garantirlo ai genitori della ragazza? NDT)…
Don Antonio con fare risoluto ordinò ai due di smetterla…
Intanto alcuni compaesani s’erano raggruppati davanti alla casa. Uno dei curiosi insinuò il sospetto che alla giovane coppia fosse stata fatta una fattura. Magari commissionata da uno dei presenti che se ne stava lì sornione. Una donna pregava per gli sposi…
Convintosi che i due fossero vittime di un maleficio, molto disperato Don Antonio fece salire su due asini Placido e Anna; e avviatosi a piedi in mezzo alle due cavalcature, per impedire che si assalissero per via, uscì dal paese…. Prese per la via di San Felice. Passato Corsano e guadato il Miscano, portò i due a Sant’Arcangelo Trimonti.
A quell’epoca Sant’Arcangelo era un villaggio di umili casette di braccianti. Uno di loro era ritenuto uno stregone di “magìa bianca”.
Lo stregone capì immediatamente che si trattava di una potente affatturazione. Portati nello scantinato i due giovani, li sottopose alle sue arti stregonesche. Per sfortuna non riuscì a togliere ad Anna la sua fattura. Non ci riuscì perché, disse: “La pozione che ha fatto il maleficio è stata tracannata tutta e vedo che non c’è speranza di ritrovarne almeno qualche goccia che potrebbe servire a liberare ‘sta figliola.”
Infatti Benigna si era disfatta del bicchiere dal quale aveva bevuto Anna andando la notte stessa del matrimonio a buttarlo nel Miscano.
Mentre si preparavano a partire, lo stregone chiese a Don Antonio il nome del loro paese. Dopo di che ordinò a Placido di rivolgere i piedi in direzione del paese, mettendo però un piede sopra l’altro. E, come fu come non fu, Placido si ritrovò sotto l’olmo di Piazza Carmine. Corse allora alla casa dei suoceri giù al Trappeto, ma trovò solo Maria. ‘Il marito e la figlia non li aveva visti da quando erano partiti con lui quella mattina’, disse la suocera allo sbalordito Placido.
[Bibliografia di riferimento]
[De Furia A.M. – De furia L.A.,The road from Ariano Irpino, Rubicon Prt. Co., Livingstone (New Jersey- USA), 2002]
